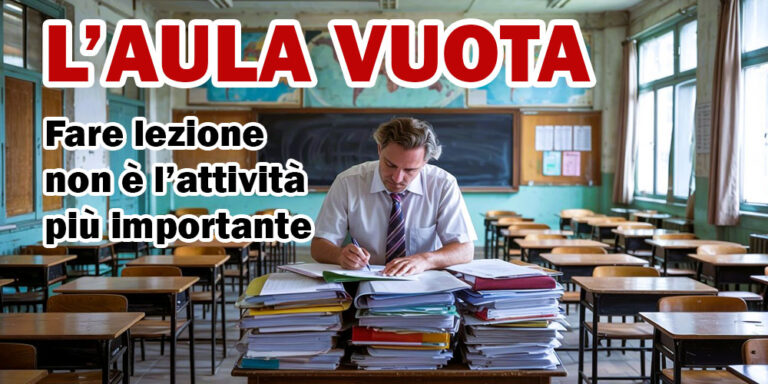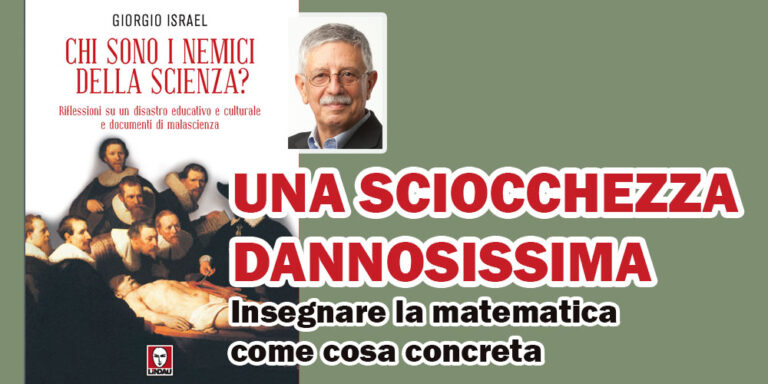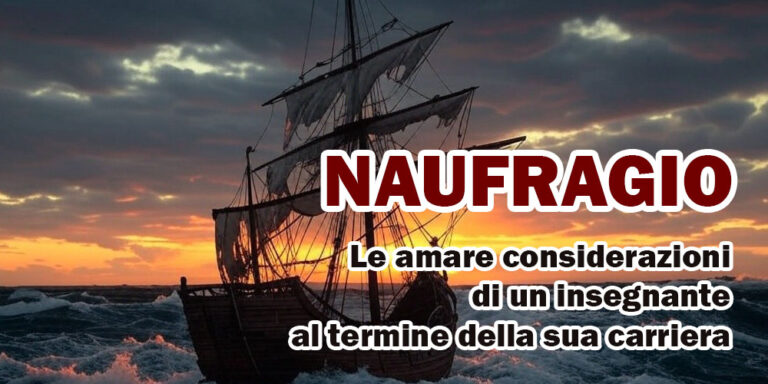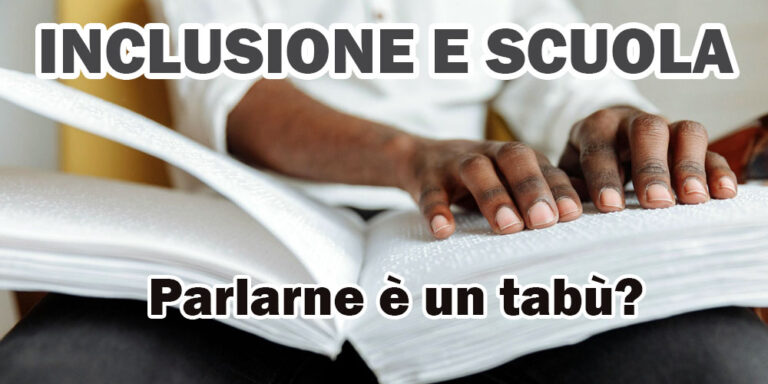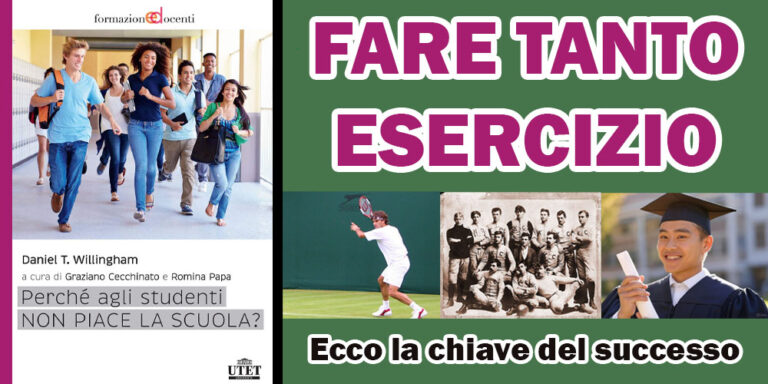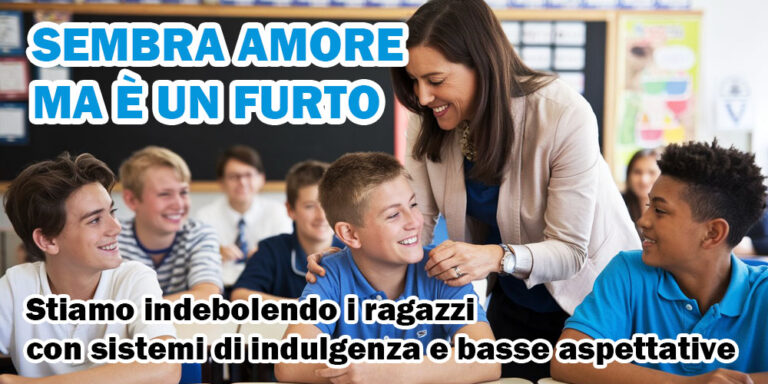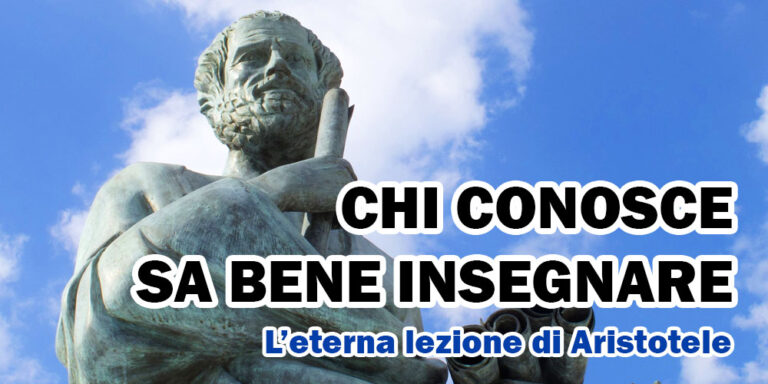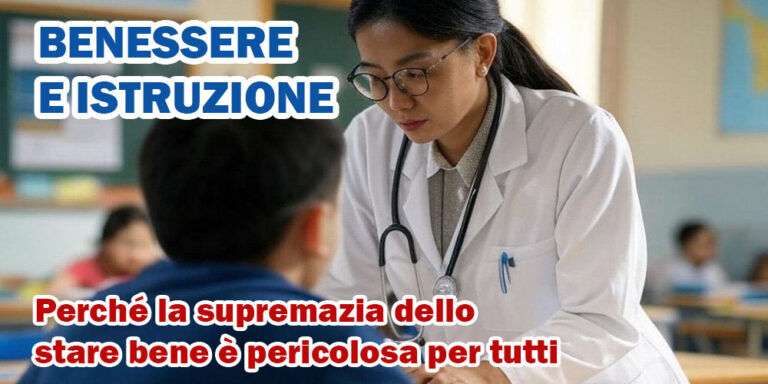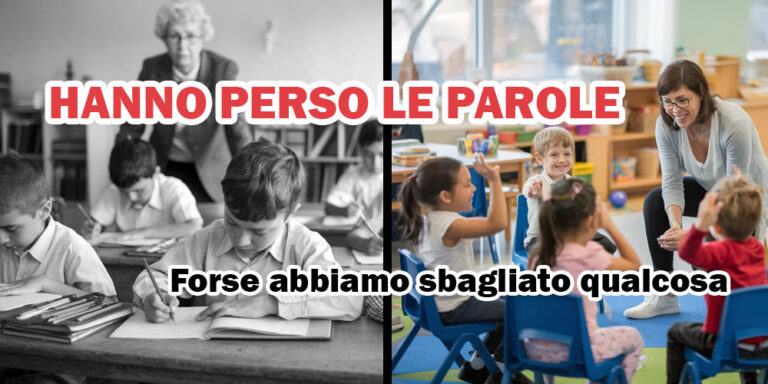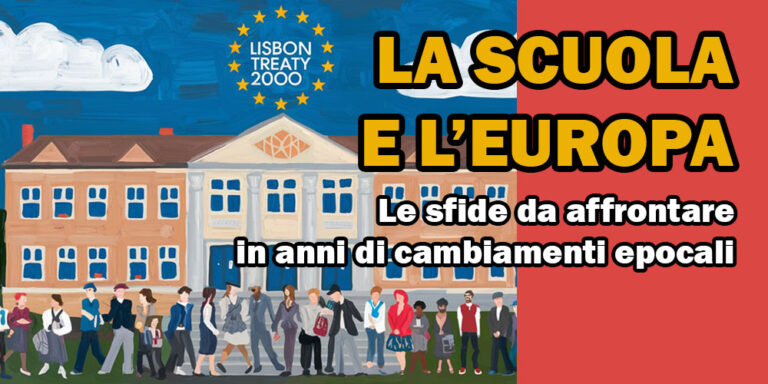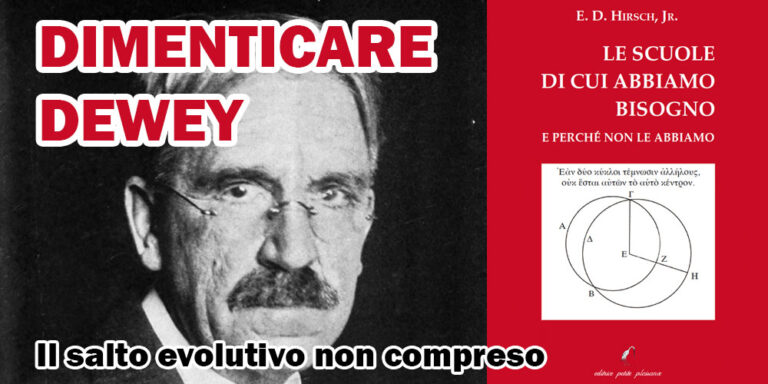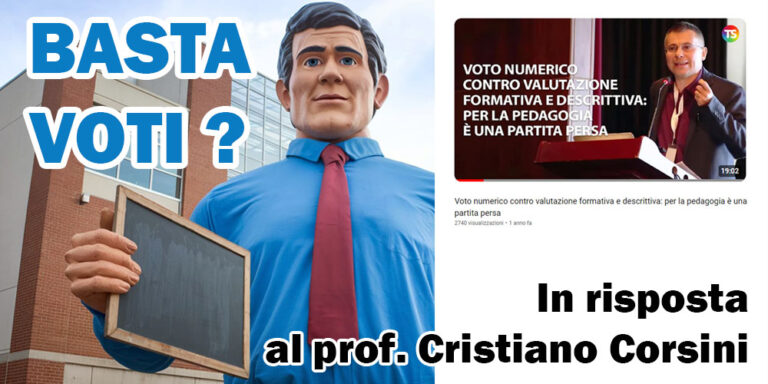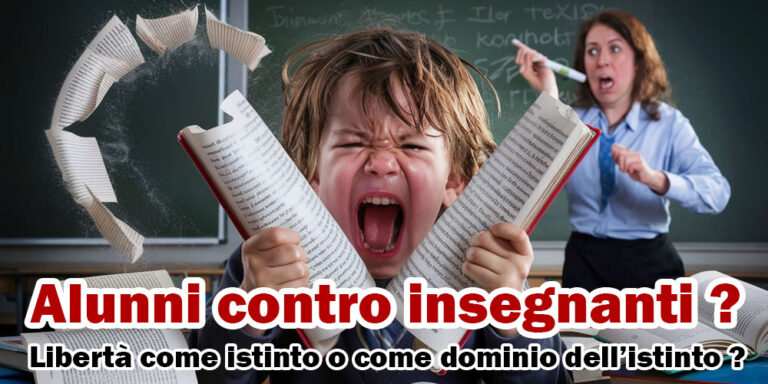Un esempio di best practice in materia di inclusione
Ci sono scuole costose, e di specializzazione metodologica avanzata, che dovrebbero mettere la museruola a tutti coloro che insorgono al sol pensiero di “percorsi speciali” per individui con profili di disabilità e neuro-divergenza. Ma in Italia siamo campioni nelle accuse, più che nelle distinzioni logiche.